Nuove geografie letterarie: Il camminare come atto di resistenza ecologica
Irene Cecchini dialoga con Wu Ming 2

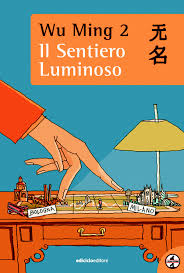
Il sentiero degli dei (2010) e Il sentiero luminoso (2016) di Wu Ming 2 sono due libri-elogio al paesaggio e insieme scritti di resistenza ecologica per rieducare all’abitare i luoghi; durante i suoi viaggi, prima fra l’Appennino tosco-emiliano poi nella Pianura Padana, Girolamo – alter-ego dello stesso Wu Ming 2 – si fa portavoce di storie naturali e partigiane che riabilitano questi territori ormai deturpati, feriti nella propria identità, soffocati dall’edilizia.
L’arma del cammino di Wu Ming 2 si inserisce all’interno di una tendenza letteraria – già ispezionata con l’intervista precedente a Simona Baldanzi (leggila qui) – ormai sempre più rintracciabile nel panorama italiano; potremmo parlare di nuove geografie narrative di resistenza, romanzi-reportage dove la riflessione ambientale diventa riappropriazione e responsabilità per attuare una pratica di riabitazione e riabilitazione del luogo.
Con la nuova ferrovia ad Alta Velocità si percorre Bologna-Firenze in 37 minuti, con il libro di Wu Ming 2 Il sentiero degli dei si segue il cammino da Piazza Maggiore a Piazza della Signoria per 5 giorni; allo stesso modo si attraversa Milano-Bologna in 55 minuti, mentre a passo d’uomo Wu Ming 2 nel suo Il sentiero luminoso ci impiega 8 giorni di cammino; attraverso questi passi e per mezzo della sua agile penna si è portati a riflettere sulla Storia e la memoria dei luoghi, sull’appartenenza al territorio e sulla sua necessaria tutela. Tra finzione romanzesca e inchiesta giornalistica Wu Ming 2 ci dice quello che dovremmo iniziare a sapere.
Irene Cecchini: Mi piacerebbe dividere l’intervista in due momenti che ci permettano così di esplorare insieme questo forte movimento d’interesse geografico dalle forme di narrative non fiction, ormai da qualche tempo registrabile nel panorama italiano ma poco studiato da una prospettiva critica. Attraverso un prima discussione più ampia che ci permetta di investigare quante e quali possibili prospettive possa avere questa riabilitazione narrativa, sposterei l’attenzione sui tuoi due libri i quali, attraverso pratiche letterarie di resistenza ecologica orizzontale – di azione diretta -, si interrogano sulle possibilità di riabilitare il paesaggio, cercando di rintracciare come le tendenze generali del riabitare siano riscontrabili nelle tue pagine.
Mi ha colpito molto il tuo inaugurare il libro Il sentiero degli dei con un punto fermo, una sentenza che circoscrive e allo stesso tempo apre varie strade all’interpretazione di questo testo; interrogandoti infatti sulla sua natura giungi alla conclusione che: “Di certo, non è letteratura”.
Eppure nella costruzione dell’opera ti poni anche dei problemi stilistici e presti attenzione all’impianto narrativo: crei il tuo alter-ego Gerolamo che a sua volta è narrato da una terza voce con slancio romanzesco, inserisci in maniera strutturale elementi di finzione, di reportage e documentazione approfondita di fonti, insieme a storie orali legate ad un passato di resistenza partigiana ma anche canzoni popolari o pensieri di altri autori senza perdere una dimensione corale dell’opera.
Non pensi che la letteratura possa mantenere un certo statuto tornando ad essere azione politica e meno dichiaratamente ricerca estetica? Se sì, in che modo la figura dello scrittore può dare il suo contributo alla comprensione dei problemi connessi alla questione ambientale ed educare ad un cambiamento nelle abitudini?
Wu Ming 2: La “nota dell’autore” che introduce Il sentiero degli dei ricalca quella scritta da Paco Ignacio Taibo II per Rivoluzionario di passaggio (De paso, 1986). In quel testo, l’autore messicano sostiene che il suo libro non è un romanzo, perché si basa su documenti e fonti storiche; quindi afferma che si tratta di un romanzo, perché usa la fantasia per ricostruire i fatti; infine (si) domanda: “Che diavolo è un romanzo?”. Dichiarando da subito che il mio libro “non è letteratura” volevo ottenere un effetto simile, proponendo varie etichette (guida per escursionisti, raccolta di novelle, diario, inchiesta) per poi scavalcarle tutte d’un colpo. E’ un modo per sottolineare che non m’interessa, a priori, la forma di un testo. Non mi metto a scriverlo pensando: “ecco, adesso produco un oggetto fatto così”, ma piuttosto parto da quel che dovrebbe fare, dal rapporto che vorrei creare con chi lo leggerà, dalla comunità che mi piacerebbe si formasse intorno ad esso. E già parlare di oggetto non mi convince fino in fondo, perché una storia cresce, si sviluppa, come una pianta, e quindi è sbagliato considerarla una cosa (oltretutto, proprio in una prospettiva ecologica, dovremmo domandarci se le cose che ci circondano non siano anch’esse soggetti, visto come ci condizionano la vita). Rispetto quindi a quel che facciamo con un testo, non credo sia importante la sua forma letteraria, quanto piuttosto altri fattori, che rientrano nel campo della retorica. Ad esempio: il livello di udibilità della voce dell’autore. Quando questa voce si sente forte e chiara – come in un saggio, per intenderci – chi legge è invitato a confrontarsi con un ragionamento in maniera frontale, e di solito può accoglierlo o rifiutarlo. Se invece l’autore sta zitto, o quantomeno si nasconde in mezzo a un narratore e vari personaggi, il risultato è diverso. Chi legge si trova di fronte a differenti punti di vista. Chi scrive ha più spazio per mostrare contraddizioni, alternative e conflitti. In breve, se l’autore parla, molto a fatica ascolterò qualcun altro. Di certo sarà molto difficile far parlare anche gli oggetti, il paesaggio. La narrativa invece offre questo vantaggio e per questo motivo è una grande palestra di incontro con l’Altro (cosa c’è di più “altro” di un personaggio che nemmeno esiste?). Di conseguenza, dal momento che per modificare il nostro rapporto con l’ambiente, con il mondo che ci circonda, dobbiamo anzitutto imparare a rispettarlo come “altro”, cioè come un soggetto da frequentare e non un oggetto da usare o uno spazio da occupare, ecco che la narrativa mi pare uno strumento utile per educarci in questo senso.
I.C.: In Italia si sta registrando una sempre maggior attenzione da parte degli scrittori verso i luoghi e la loro tutela, tanto che sarebbe possibile iniziare a tracciare delle linee teoriche di questo movimento che io chiamo di resistenza ambientale per la riabilitazione e riabitazione del luogo: penso a Franco Arminio paesologo, a Carmen Pellegrino che si definisce « abbandonologa », ma ancora a Paolo Rumiz e Simona Baldanzi, Wu Ming 1 e Antonio Moresco e la Repubblica Nomade, i quali attraverso i loro scritti riescono a non fossilizzarsi nel racconto d’inchiesta e puramente documentario per elaborare un’estetica nuova dei luoghi minori, alternando sentimenti elegiaci, wilderness pura, ma anche istanze politiche e di etica ambientale.
Ti ritrovi all’interno di questa definizione e questa compagnia? Ti sentiresti di consigliarmi altri autori che potrebbero rientrare in questa narrativa ecologica?
W.M. 2: Senz’altro mi ritrovo in questa compagnia e sono lusingato di farne parte, anche se già intravedo i rischi di questa tendenza. È chiaro che il sistema economico estrattivista, che trasforma tutto in risorsa da espropriare, cercherà di soggiogare la “mente locale” per metterla al lavoro nell’industria turistica. Si ripeterà – si sta già ripetendo – quel che è successo con l’abbraccio mortale tra Eataly e SlowFood, tra agricoltura biologica e supermercati, tra commercio equo e Starbucks. Ossimori tenuti insieme da narrazioni tossiche. Nel Sentiero luminoso racconto che l’outlet “Fidenza Village” offre ai suoi clienti un pacchetto di visita che comprende: andata e ritorno da Milano con servizio navetta (140 Km), mattinata di shopping e pomeriggio a piedi sull’antica Via Francigena – rivendicando così un’attenzione al genius loci, alle peculiarità del territorio. Non solo quindi la riscoperta dei luoghi può diventare un paravento per distruggerli o per espellere chi li abita, ma rischia di essere l’apripista di questo processo. È un risultato che sarà tanto più probabile quanto più ci si limiterà ad affrontare la questione in termini soltanto estetici o culturali. Se il paesaggio è un bel quadro, posso staccarlo dal muro e venderlo all’asta. Se è una “mappa mentale”, posso trasformarlo in una brochure, o in un’app di realtà aumentata, che lo animi anche da cadavere. Se invece l’essenza dei luoghi consiste in un certo modo di abitarli, allora sarà più faticoso espropriare questo nocciolo a dispetto degli abitanti stessi.
In questa prospettiva, credo si possano aggiungere all’elenco che suggerisci scrittori come Luigi Nacci, Matteo Melchiorre, Davide Sapienza, Luca Gianotti, Matteo Meschiari e i lavori di Franco La Cecla sull’antropologia dell’abitare (Perdersi e Mente Locale).
I.C. : Quando parlo di riabitare narrativo mi riferisco all’idea di Peter Berg e Raymond Dasmann di reinhabitation of the place, di abitare coscientemente un luogo, divenendo così consapevoli delle particolari relazioni ecologiche che equilibrano quella determinata bioregione così da collaborare congiuntamente al mantenimento del luogo stesso, senza limitarsi allo “stare da qualche parte”.
Ho utilizzato il termine bioregione, che potremmo definire come una zona geograficamente rintracciabile non attraverso confini politici definiti ma seguendo caratteristiche ecologiche e storiche come la conformazione del terreno, il clima, la distribuzione delle specie ma anche i problemi sociali o ambientali che le affliggono.
Ti ritrovi in questo modo di pensare ed agire? Pensi che anche per voi scrittori di resistenze ecologiche sia più immediato e naturale agire sui propri territori?
W.M. 2: Anzitutto, bisogna capire cosa s’intende per “propri territori”. Finché parliamo di proprietà private, istituzioni o cimiteri, sembra facile stabilire un confine. Dentro/fuori. Ma già se consideriamo una vallata, una città, o lo spazio che nomino quando dico “qui”, è molto complicato deciderne l’estensione. I luoghi nascono come incroci di percorsi, e quindi sono definiti dalle linee che li attraversano, piuttosto che da quelle che li chiudono. “Abitare coscientemente un luogo” significa conoscere quegli andirivieni, ovvero i movimenti di chi lo vive, senza bisogno di una mappa – mentale o cartacea che sia. Si potrebbe dire che proprio quando inizi ad aver bisogno di una mappa, allora non appartieni più al territorio in cui cammini. Gli autoctoni sono coloro che si orientano in un luogo grazie alle storie, non alla bussola. Ma fino a che punto devono conoscere i percorsi che in un luogo s’incontrano e che lo definiscono? Se una città portuale X ha rapporti abituali (di pesca e di scambi) con una città Y, che sorge dall’altra parte del mare, a 100 miglia di navigazione, posso dire di conoscere X senza conoscere Y, e la rotta che le unisce ogni giorno, coinvolgendo migliaia di abitanti? I limiti di un luogo dipendono anche da come lo abito, cioè da come vado in giro. Se devo muovermi a piedi, allora non so dirti nemmeno come andare da Bologna, la mia città, a Molinella, che sta a 30 km, ma già non appartiene più al luogo dove “abito-a-piedi”. Se invece vado tutte le mattine in treno a Sasso Marconi, allora quel paese rientra nel luogo dove “abito-con-i-mezzi-pubblici”. Senza bisogno di scomodare Einstein, sappiamo che gli spazi sono tanti e cambiano a secondo del movimento dell’osservatore. Quando ho camminato sul Sentiero Luminoso, di fianco all’autostrada o alla linea ad Alta Velocità, ero in un luogo diverso da quello degli automobilisti e dei passeggeri che sfrecciavano a meno di cinque metri dalla mia spalla. In alternativa, si potrebbe dire che il “mio territorio”, il luogo al quale appartengo, è quello che abito con continuità, intesa in senso spazio-temporale. Se lavoro a Sasso Marconi e ci vado in treno tutte le mattine, forse Sasso Marconi può essere uno dei “miei territori”, ma quello che si estende tra le stazioni di Bologna e Sasso non lo è, perché lo attraverso dentro al treno e quindi sono davvero da un’altra parte (magari potrei considerare il treno Bologna – Sasso delle 7.45 come uno dei “miei territori”, ma non la frazione di Pontecchio, dove spesso il convoglio non ferma nemmeno).
Per tutte queste ragioni, quando voglio raccontare un luogo, preferisco seguire la linea di un sentiero piuttosto che tracciare quella di un confine. Anche il termine “bioregione” mi lascia perplesso, perché si presta a diventare un concetto politico-amministrativo, riproponendo l’idea di nazioni “più naturali” di quelle storiche, e quindi anche “migliori”, perché delimitate da frontiere “scientifiche” e non ideologiche.
Credo quindi che la “resistenza ecologica” – con qualunque strumento la si pratichi – debba sempre confrontarsi con le questioni locali, ma senza dimenticare il rapporto che ognuno di noi intrattiene con le “terre straniere”, attraverso il turismo, il viaggio, i traslochi della vita, il lavoro, le parentele a distanza.
I.C.: La riabitazione che metti in atto si verifica per mezzo di un narratore che si fa collettore di memorie passate e recenti così che la narrazione stessa diventa una voce della collettività; questo avviene per le storie partigiane presenti in entrambi i volumi ma anche per la storia della Direttissima o dell’Alta Velocità fra Milano e Bologna con le sue morti bianche e non.
Queste storie, che potrebbero sembrare spaccati momentanei di interruzione alla narrazione, se viste da una prospettiva più ampia altro non sono che una testimonianza di una continuazione storico-geografica del luogo stesso con lo scopo di rievocare nel lettore una nuova partecipazione al vissuto del luogo e forse una necessità di conoscerlo più a fondo.
Lo spazio geografico diventa mappa storica, nella quale si possono rintracciare i segni di ciò che è avvenuto e così ricordare per far rivivere il luogo. Come scrive Ricoeur in Dal testo all’azione occorre “riaprire il passato, ravvivare le potenzialità incompiute, impedite, addirittura massacrate”.
Come pensi che l’oralità e la memoria possano interagire all’interno del discorso ecologico?
W.M. 2: Di recente, con il fotografo Giancarlo Barzagli, abbiamo pubblicato un libro (Grüne Linie) che racconta la resistenza antifascista sull’Appennino tosco-romagnolo, attraverso l’esplorazione di una piccola vallata, sede della 36ª Brigata Garibaldi. Spesso ci ripetiamo che stanno morendo, una dopo l’altro, gli ultimi testimoni di quell’epopea, ma se il paesaggio è un organismo vivente, allora perché non considerarlo un testimone vivo degli avvenimenti che lo hanno plasmato? Non parlo solamente di tracce riconoscibili, perché se ci limitassimo a quelle tratteremmo il paesaggio come un oggetto, un testo che attende la nostra interpretazione e acquista significato solo quando lo rivestiamo con una coperta culturale, estratta dalle nostre menti. Questo atteggiamento è il contrario di una qualunque prospettiva ecologica. Ritengo invece che si possa conoscere il paesaggio come si conosce un’altra persona. Per farlo, è senz’altro importante capire la sua lingua, ma molto di più passa attraverso l’empatia, lo stare insieme, il rispondere alla presenza dell’altro. Siamo abituati a rapportarci al paesaggio in termini per lo più visivi, dimenticando che camminare in un luogo significa toccarlo ad ogni passo. Il piede risponde alle sollecitazioni di un terreno che è stato modellato dal viavai di moltissimi essere viventi, in epoche diverse. In questo senso, il passato di un territorio è molto più che una semplice iscrizione, che posso leggere se conosco quell’alfabeto. E’ un passato presente. Incide sul mio modo di abitare, e ne rimane inciso. Il paesaggio non è soltanto il teatro di eventi passati, il palcoscenico dove si sono esibiti altri esseri in un altro tempo. Quella che incontro quando lo percorro non è una vecchia scenografia, ma quella che Tim Ingold chiama “architessitura”, un arazzo dove ciascuno, con i suoi gesti e la sua presenza, inserisce un nuovo filo.
Per questo i luoghi serbano memoria anche delle potenzialità inespresse, quelli che in molti testi, insieme a Wu Ming 1, abbiamo chiamato “fantasmi”. I fantasmi stanno nel paesaggio, come il pane sta nella parola compagno. Puoi anche non accorgerti di loro, perché sono assenti, ma in realtà sono attivi. In un mondo che è in continuo divenire, nessuna attualità cancella le potenzialità che non si sono realizzate. Nessun presente può sopprimere i futuri abbandonati. Quando una cosa diventa un’altra, si crea un rapporto tra il prima e il dopo, dove a ben guardare nessuno dei due momenti scompare davvero fino in fondo – altrimenti, che rapporto sarebbe? Allo stesso modo, quando un essere vivente muore, la morte non cancella la vita, e questa continua ad esprimersi in tracce, segni, influenze. Ecco perché quando cammino in un paesaggio mi sento “posseduto”. Sento di dialogare con i morti, in un senso tutt’altro che metaforico. Le mie gambe rispondono alle impronte del passato, il mio corpo tesse il suo filo in mezzo ad un ordito che si è formato in migliaia di anni. I luoghi ricordano e ci aiutano a ricordare, ma anche a trovare nuove memorie, nuovi sentieri di rimembranza.
I.C.: In apertura al libro Il sentiero degli dei usi una citazione da Eugenio Turri “Ogni atto sul territorio è un atto politico”; in La conoscenza del territorio: Metodologia per un’analisi storico-geografica, Turri stesso sembra parlare di riabitazione poiché sostiene che “solo la conoscenza del territorio è l’indispensabile bagaglio culturale senza il quale la popolazione perde il senso del rapporto con il territorio”.
È per questo che insieme alla narrazione più romanzesca o orale hai deciso anche di inserire importanti passaggi di pura inchiesta e arricchire i libri con note a pié di pagina che permettano al lettore di orientarsi in una personale documentazione? E rispetto alla citazione il tuo camminare che atto politico vuole essere?
W.M. 2: Abbiamo sempre definito tutta l’attività del nostro collettivo come un dialogo tra l’archivio e la strada. Tra la ricerca di fonti e l’azione diretta, tra lo scrivere libri e il portarli tra la gente, tra la raccolta d’informazioni e l’esperienza sul campo. Crediamo che la conoscenza sia una sintesi di questi due aspetti e quindi che non possa essere sganciata da una dimensione locale. La conoscenza astratta… è un’astrazione, di per sé non esiste, si conosce sempre qui ed ora, in un qui ed ora. Per questo la metafora del “bagaglio culturale” non mi convince del tutto, perché un bagaglio è qualcosa che puoi trasportare da un luogo all’altro, senza che il contenuto si modifichi o perda valore. Invece la conoscenza – e in modo particolare la conoscenza del territorio – non è un bagaglio e non è nemmeno una “mappa mentale”, che sta lì, nella tua mente, a prescindere da quel che c’è fuori, al punto che non puoi capire quel che c’è fuori se non hai quella mappa, quel bagaglio nella testa. Di nuovo: questa non mi pare una prospettiva ecologica, perché ci suggerisce che per capire il mondo dobbiamo guardarlo dall’esterno. Dobbiamo predisporre nella nostra mente tutta una serie di categorie e soltanto allora possiamo dare un senso a quel che si trova “là fuori”. In realtà, noi siamo già “dentro” quel “là fuori”. Ne siamo parte, lo abitiamo, ed è proprio abitandolo che gli diamo un senso, non tirando fuori dalle nostre teste significati pronti all’uso. Ci sono libri dove si dice che gli esseri umani hanno cominciato a concepire il paesaggio a partire dall’epoca tal dei tali. Oppure si dice che ci sono gruppi umani che non vivono nel paesaggio, ma soltanto nel territorio “fisico”. A me pare assurdo, perché il paesaggio, cioè il senso che attribuiamo agli elementi di un territorio, non nasce da un’operazione mentale, cerebrale o estetica. Nasce dall’abitare. Quindi anche una pulce concepisce un paesaggio, per quanto strano possa sembrare a noialtri dominatori dell’Universo.
Turri dice che senza la conoscenza del territorio si perde il senso del rapporto con esso. Io non credo sia così. Penso che un senso lo si trovi comunque, anche andando in skateboard tra le rovine di un’autostrada incompiuta. Anche gettare una colata di cemento su ettari di campi incolti ha “un senso”. Quindi quello che si può “perdere” non è tanto il senso di quel che facciamo nell’abitare un luogo, quanto piuttosto la vitalità del territorio stesso. Il paesaggio cambia, è inevitabile. Pensare di conservarlo è come voler “conservare” un bambino di tre anni. Quello cresce, non c’è niente da fare – a meno di ucciderlo e imbalsamarlo. Però può crescere sano oppure malato, socievole o depresso, pieno di vita o stanco morto. Ci sono interventi sul territorio che uccidono molte sue forme di vita, o le rendono impossibili, e di conseguenza soffocano quel luogo. E ce ne sono altri che, pur modificandolo, aggiungono fili all’architessitura. La conoscenza del territorio è la conoscenza delle sue forme di vita, dei suoi fili, dei suoi movimenti, che sola può permetterci di abitarlo rispettandoli, dialogando, adattando la nostra presenza a quel che già c’è, per non correre il rischio di fare il contrario: adattare l’altro a quel che noi siamo, impedendogli di essere altro.
Camminare è allora un modo per tenere insieme l’archivio e la strada. Per ribadire che non si può osservare il mondo stando fermi, seduti a una scrivania o dall’alto di un bel punto panoramico. E’ un modo di trasformare le storie in conoscenza. È uno strumento per incontrare fantasmi e raccontare le loro storie. Perché quelle storie influenzano le persone e solo conoscendole meglio gli abitanti di un luogo possono vivere meglio e combattere in maniera più efficace per vivere meglio. Come diceva Marx, non soffriamo solo dai vivi, ma anche dai morti. E camminare ce li fa incontrare entrambi.
I.C.: Restando sempre sul concetto di riabitazione, nel Il sentiero luminoso Gerolamo non segue più un tracciato ben segnalato dal CAI, appartenente ad una lunga tradizione di camminatori, come nel Sentiero degli dei, ma inventa il suo sentiero personale che possa portarlo a piedi da Bologna a Milano.
In questo caso mi sentirei di dire che metti in pratica una doppia azione riabitativa: infatti non dai solo voce a un luogo marginale come la Pianura Padana, ma la indaghi da una prospettiva anomala (come potrebbe essere quella adottata da Rumiz o dalla Baldanzi di osservare il luogo circostante navigando su un fiume) e reinventi così un luogo o un possibile cammino in un territorio sempre più rassegnato e maltrattato, il quale talvolta viene completamente privato dalla possibilità di essere camminato.
Perché non ti è bastato seguire la strada provinciale delle anime asfaltata ma hai sentito la necessità di inventarti un tragitto mai battuto da nessuno? Pensi sia ancora possibile in una società frenetica e cementizia come la nostra riuscire a reimpossessarsi di un territorio oramai usurpato -Calatrava come esempio- tanto da farlo ridiventare paesaggio e non più panorama o non-luogo?
W.M. 2: Come scrivevo più sopra, non sono più convinto – un tempo lo ero – che esistano davvero dei “non-luoghi”, delle “atopie”, dei “territori senza paesaggio”. Piuttosto, esistono luoghi al massacro, oppure paesaggi che vengono asserviti a una logica da cartolina, trasformati in superfici, a due dimensioni, dove molto a fatica ci può essere spazio per un corpo. Tuttavia, questo processo non raggiunge mai un grado zero. Il cosiddetto “terzo paesaggio”, gli spazi indecisi, le architetture incompiute, gli edifici abbandonati, sono lì a dimostrarcelo. C’è sempre qualcosa che riesce a dar loro un senso, che sia un boschetto di ailanti, un nido di rondini o una banda di ragazzine che va a farsi le canne.
Attraversare a piedi la Grande Pianura da Bologna a Milano è stata un’occasione per riscoprirla come “luogo pedonale”, per sottolineare come quel territorio sia organizzato in modo da rendere difficilissima la sopravvivenza di chi si muove su gambe o zampe. E cosa si perde, quando un luogo non viene più camminato? Un tipo insostituibile di conoscenza, fatto appunto di incontri con fantasmi, di immersione nel paesaggio, di rapporto fisico con le tracce del passato, di empatia con l’essere vivente del quale facciamo parte, come i batteri intestinali fanno parte di noi. Camminando siamo molto più sensibili a quegli aspetti del nostro abitare che sono nocivi per noi stessi, in quanto esseri viventi dotati di corpi, polmoni, gambe. Finché stiamo chiusi in un’auto, o su un altro mezzo di trasporto, oppure in un centro commerciale o in casa o in ufficio, non ci rendiamo conto di questo e continuiamo a scavarci la tomba come se niente fosse, pensando di gettare le fondamenta di una nuova, meravigliosa civiltà.
I.C.: Il camminare come forma di riabitazione e riabilitazione è la pratica di respons-abilità più immediata e in presa diretta, che agisce senza filtro sul luogo stesso, tanto che l’immersione e la rivendicazione di una coscienza geografica rappresentano la scelta principale messa in pratica anche gli altri autori citati precedentemente. La lentezza del camminare si pone così come prima forte distinzione contro il mito contemporaneo della velocità.
Ti ritrovi in questa riflessione? Come pensi possa evolversi sia nel tuo futuro lavoro di scrittore che in un’ottica letteraria più ampia?
W.M. 2: Camminare è il modo più semplice e immediato di fare il paesaggio. Se attraverso a piedi un bosco fitto, il mio gesto trasforma il territorio, e genera un segno che può aver senso per chi passa di lì dopo di me: non un senso recondito e misterioso, da interpretare, ma semplicemente un varco che dice: “vieni, di qua”. Anche per questo trovo insensato chi sostiene che nella preistoria l’umanità non percepiva “il paesaggio”. Un qualunque gruppo di cacciatori-raccoglitori aggirandosi in un territorio lo dissemina di segni e significati, lo plasma e lo trasmette alla generazione successiva. Sta qui la radice del senso di appartenenza a un luogo: lo cammino, lo modifico, ripercorro i sentieri che ho già camminato e li rendo ancor più tangibili. Me ne prendo cura. Lo riconosco: “di qui ci sono già passato”. Ricordo quel che mi è successo mentre camminavo lì.
La questione della lentezza è centrale per molti motivi: anzitutto, pone il camminare in continuità con le lotte che si agitano nella pancia del capitalismo, dalla rivoluzione industriale fino ai nostri giorni, e che sono, alla radice, lotte per sottrarsi a un tempo imposto, a un tempo omogeneo, a un tempo che cancella altri tempi – altre forme di vita. Al tempo del produci/consuma/crepa, al tempo della fabbrica e dei “tempi moderni”; in secondo luogo perché ribadisce, con un esempio pratico, che è il tempo – e non lo spazio – la dimensione più implicata nell’attaccamento a un luogo. Questo può sembrare paradossale, eppure camminando lo sperimentiamo bene. Come scrivevo prima, chi conosce un territorio non ha bisogno di mappe, cioè di rappresentazioni spaziali. Non ha bisogno di guardare dall’alto, di assumere il punto di vista di Dio, o di un satellite. Sperimenta un’onniscienza diversa, dal basso. Orizzontale, non verticale. Basata sull’accumulazione e non sulla visione d’insieme. Chi ha questa conoscenza si muove nello spazio grazie alle storie: sa come andare da A a B perché ci è andato molte volte, e ha conservato un ricordo di quel movimento. Sa dove si trova perché sa raccontare i percorsi che da lì partono e lì arrivano, a prescindere dalla sua capacità di collocarli in una rappresentazione spaziale. Ma se la sua conoscenza è di questo tipo – storie, non mappe – allora è una conoscenza temporale, perché le storie hanno a che fare con il tempo, sono diacroniche, mentre le mappe sono sincroniche. In un articolo del 1980, Italo Calvino scriveva che: “La necessità di comprendere in un’immagine la dimensione del tempo insieme a quella dello spazio è all’origine della cartografia. La carta geografica, anche se statica, presuppone un’idea narrativa, è concepita in funzione di un itinerario, è Odissea.”
L’affermazione è vera, se riferita alle “origini della cartografia”. Le mappe in effetti nascono dai viaggi, sono resoconti, ma nei secoli hanno perduto quella dimensione. Hanno eliminato immagini di velieri e mostri marini. Hanno espulso il tempo, il movimento, il divenire, gli abitanti. Al punto che oggi è proprio questo congelamento che ne definisce l’oggettività scientifica. Quindi, con buona pace di Calvino, il tempo e le mappe hanno ormai divorziato. Camminare è un modo per ribadire l’importanza di “prendere tempo”. Il che non significa che qualunque spostamento dev’essere fatto a 5 chilometri all’ora, ma che per conoscere bisogna aggirarsi lentamente nello spazio – geografico o culturale che sia. La letteratura, in questo, è sorella della viandanza, perché anch’essa mira a rallentare l’informazione, a scavare bacini dove il flusso dei dati si distenda, per permetterci di analizzare la qualità dell’acqua e osservare i pesci che guizzano sotto la superficie.
I.C.: Un’ultima domanda sul tuo lavoro personale e all’interno del collettivo Wu Ming, che si mostra molto attivo e interessato alla questione ambientale soprattutto sul vostro sito Giap! ma anche fra i singoli membri ( per esempio Wu Ming 1, Un viaggio che non promettiamo breve. Venticinque anni di lotte NoTav).
Hai intenzione di proseguire questo cammino a piedi con nuove resistenze ecologiche narrative?
W.M. 2: A giugno di quest’anno vorrei proseguire il cammino sulle tracce della linea ad Alta Velocità. Dopo Bologna – Firenze e Bologna – Milano vorrei andare da Milano a Torino, ma questa volta senza mappe, senza bussole, orientandomi soltanto con il paesaggio e dormendo dove capita, per interrogarmi sull’idea di casa attraverso l’esperienza opposta: quella di muoversi senza punti di riferimento in una terra straniera. La casa, negli ultimi anni, è una metafora politica molto abusata, e si sentono ripetere di continuo espressioni come “a casa nostra”, “a casa loro”, “a casa!”. Se camminare è già un modo per farsi una casa nel mondo, voglio capire meglio come succede e come si può evitare che il senso di attaccamento ad un luogo diventi una forza reazionaria, alleata dell’eterno fascismo.
Per citare questo articolo:
Wu Ming 2, Irene Cecchini, Nuove geografie letterarie: il camminare come atto di resistenza ecologica. Irene Cecchini dialoga con Wu Ming 2, in Literature.green, Maggio 2019, URL: https://www.literature.green/nuove-geografie-letterarie-il-camminare-come-atto-di-resistenza-ecologica. Pagina consultata il [data]
